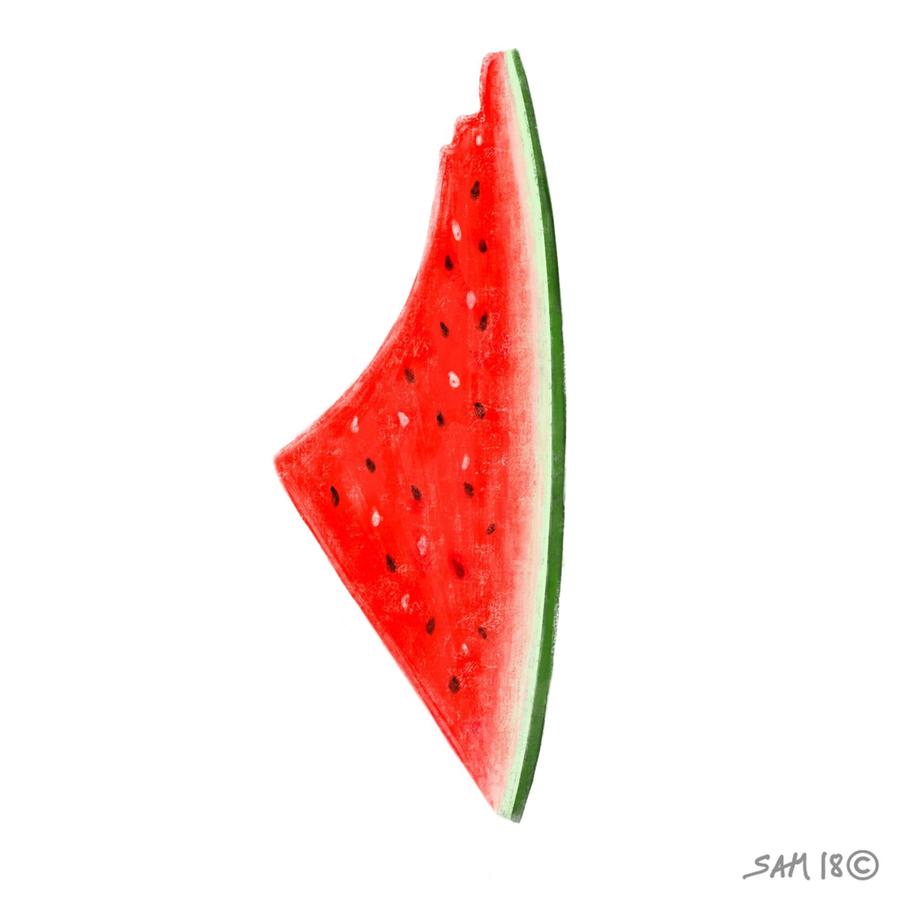Un’anguria non è solo un’anguria in Palestina
È stata adottata da artisti e illustratori locali, diventando un simbolo di resistenza

Forse non ci avete mai fatto caso, ma i colori dell’anguria sono gli stessi della bandiera palestinese. Un’incredibile coincidenza che ha trasformato il frutto estivo in un simbolo di resistenza.
Il primo a raccontare questa storia è stato Jackson Connor su Vice. In un articolo del 2015 Connor spiegava come, dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967, qualsiasi manifestazione politica contro Israele fosse stata proibita. Era stata bandita anche l’esposizione della bandiera palestinese o di altri simboli che ne ricalcassero i colori.
Così, per aggirare il divieto, è possibile che in quel periodo molti attivisti avessero cominciato a utilizzare le fette di anguria come forma di protesta, anche se non ci sono certezze su questa ipotesi.
Connor racconta anche come, nel 1993, il New York Times avesse pubblicato un reportage in cui tracciava una correlazione tra alcuni arresti seguiti alla firma degli Accordi di Oslo e il fatto che le persone coinvolte avessero con sé pezzi di anguria. Dopo qualche tempo, tuttavia, il giornale smentì questo dettaglio, sostenendo di non poterne confermare la veridicità.
I colori dell’anguria sono gli stessi della bandiera palestinese. Una coincidenza che ha trasformato il frutto in un simbolo di resistenza
L’episodio che sancì la consacrazione dell’anguria come simbolo della resistenza palestinese avvenne nel 1980, durante una mostra organizzata all’interno della Galleria 79, a Ramallah. La mostra degli artisti Nabil Anani, Sliman Mansour e Issam Badr venne repentinamente interrotta dall’esercito israeliano per la valenza politica di alcune opere con la bandiera palestinese.
Recentemente Mansour ha raccontato l’episodio alla rivista The National, in un’intervista ripresa anche dal sito Astarte Edizioni. Mansour ha ricordato che a poche settimane dallo sgombero, gli ufficiali israeliani convocarono i tre artisti, consigliando loro di smettere di fare politica e di dipingere piuttosto dei fiori. “Ci dissero che dipingere la bandiera palestinese era proibito e che anche i suoi colori lo erano” ha raccontato Mansour. “Allora Badr chiese: e se facessi un fiore rosso, verde, nero e bianco? E l’ufficiale rispose: sarà confiscato. Anche se dipingi un’anguria, sarà confiscata”.
L’episodio che consacrò l’anguria come simbolo avvenne nel 1980 in una galleria di Ramallah
Da allora diversi artisti hanno raccontato di aver rischiato il carcere per aver dipinto o raffigurato angurie nelle loro opere. Il quotidiano australiano The Age ha raccontato come il frutto sia diventato un simbolo soprattutto durante la Seconda Intifada nel 2000.
A distanza di anni, il primo a riprendere il tema dell’anguria è stato l’artista Khaled Hourani, che nel 2007 ne dipinse una nell’ambito del progetto Subjective Atlas of Palestine. Dopo gli scontri delle ultime settimane, che hanno riacceso i riflettori sul conflitto israelo-palestinese, il suo lavoro ha ricevuto nuova visibilità. Sempre su The National l’artista ha raccontato che non si aspettava che la sua anguria ricevesse tanta attenzione mediatica. “C’è chi se l’è fatta tatuare, chi ci decora i vestiti, chi la mette sulle bandiere. Sono felice che la mia opera contribuisca a far luce sulla questione palestinese”.
Da allora diversi artisti hanno rischiato il carcere per aver raffigurato angurie nelle loro opere
Sarah Hatahet, un’illustratrice giordana che vive a Abu Dhabi, dice di aver scoperto l’opera di Hourani attraverso i social e di averne tratto ispirazione per realizzare un’opera simile. E così hanno fatto molti altri artisti, come Sam Boukhari, Aya Mobaydeen, Beesan Arafat, le cui angurie spopolano sui social e vengono ricondivise specialmente dai giovanissimi.
Secondo la storica dell’arte Salwa Mikdadi, curatrice della prima mostra sulla Palestina presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, prendere di mira gli artisti e gli spazi culturali è una tattica volta a cancellare l’identità del popolo palestinese. “L’obiettivo è deumanizzare il popolo palestinese, lasciandolo senza cultura e senza passato (…). L’arte è da sempre considerata un mezzo pericoloso, perché riesce a mobilitare l’opinione pubblica molto più della politica”.
Mikdadi ha spiegato che i social hanno contribuito a riaccendere i riflettori sull’occupazione dei territori palestinesi, dando visibilità ai messaggi degli attivisti, molto più di quanto abbiano mai fatto i media tradizionali, e offrendo alle voci palestinesi uno spazio senza intermediazioni. Anche Mansour è della stessa idea: “C’è chi vuole negare la nostra esistenza, cultura e identità. L’arte si oppone a tutto ciò, dando una casa a chi è rimasto senza tetto”.