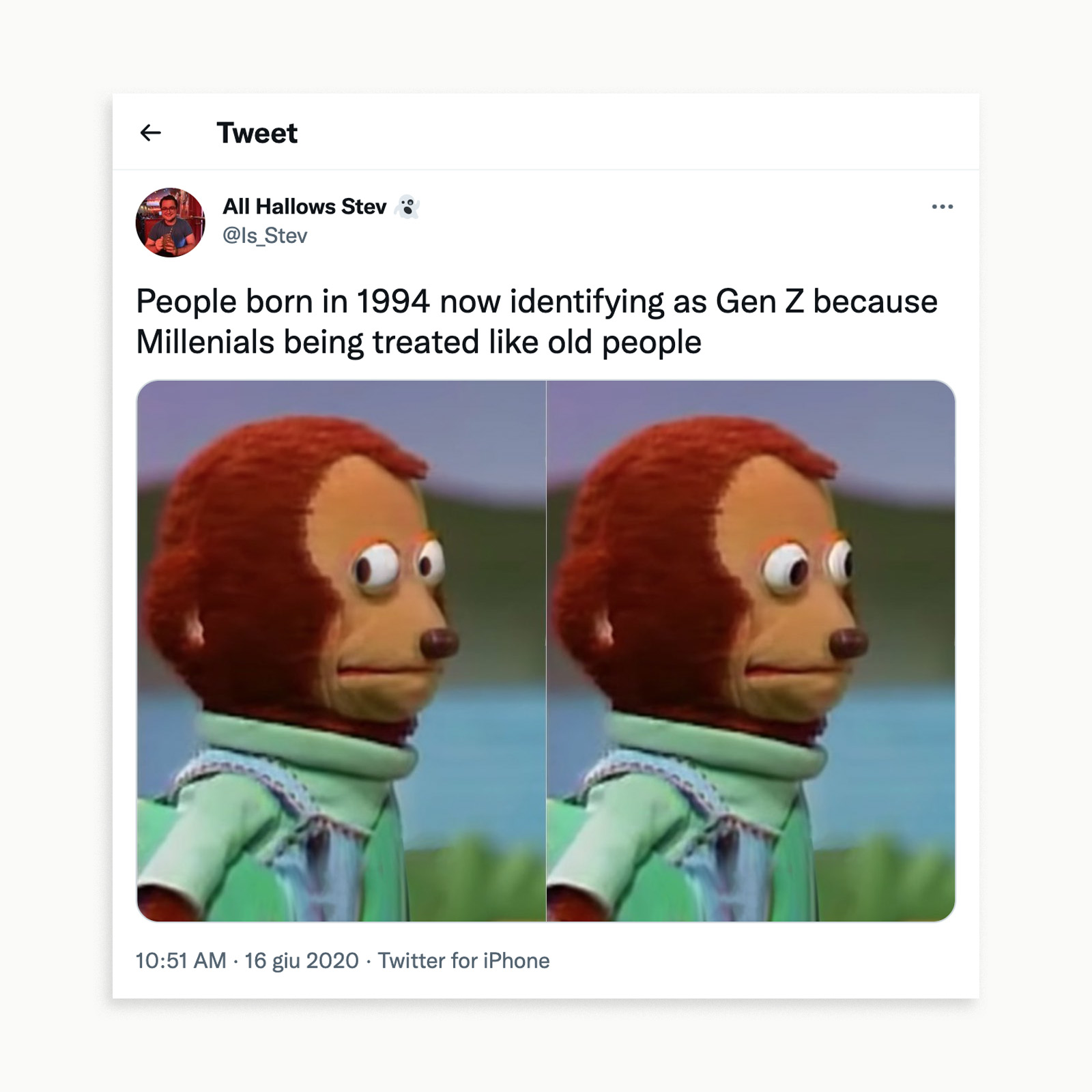Se avete mai digitato “millennials” o “Gen Z” nella barra di ricerca di Google saprete che esistono centinaia di analisi di mercato che provano a spiegare chi sono le “nuove generazioni”, come pensano, cosa sognano.
Cercando le due espressioni contemporaneamente, troverete articoli (come questo di Forbes, per esempio) che giurano di svelare ogni minima differenza tra i due gruppi, prendendo in esame gusti e abitudini d’acquisto.
L’obiettivo è sempre lo stesso: guadagnarsi la fiducia di questə utentə per comunicare efficacemente con loro. E in sostanza, vendergli qualcosa meglio di qualcun altro.
Fino a qualche decennio fa, il concetto di generazione così come lo intendiamo oggi non esisteva. Va bene, nel suo memoir Festa Mobile, Ernest Hemingway parlava della propria come di una “generazione perduta”, citando un aneddoto di Gertrude Stein, sua mentore e mecenate. E sì, nel 1951, un articolo di TIME (con un incipit spaventosamente bello e contemporaneo) utilizzò per la prima volta l’espressione “Silent Generation” per riferirsi alle persone nate tra il 1928 e il 1948.
A nessuno era ancora venuto in mente che semplicemente coniando nuovi termini particolarmente orecchiabili fosse possibile categorizzare milioni di persone, accomunate esclusivamente dal fatto di essere nate in un certo lasso di tempo e, sfruttare queste presunte caratteristiche in comune per vendere loro qualcosa. Un nuovo arredo per la casa, un paio di scarpe, uno stile di vita.
Furono i sociologi Neil Howe e William Strauss, nel saggio Generations, i primi a utilizzare l’espressione millennial per indicare le persone nate tra il 1980 e il Duemila. A renderla popolare, attribuendogli un’accezione per lo più negativa, fu ancora una volta TIME. Nell’articolo The Me Me Me Generation, pubblicato nel 2013, la rivista descriveva i Millennials come una generazione di narcisistə egoriferitə, talmente innamoratə di sé da passare la maggior parte del tempo a documentare ogni dettaglio della propria vita sui social.
Fino a qualche decennio fa, il concetto di generazione così come lo intendiamo oggi non esisteva.
Tanto per rincarare la dose, nel 2017, un articolo su The Guardian asseriva che la precarietà economica di questa generazione era una conseguenza della sua incapacità di rinunciare ai piccoli vezzi della vita quotidiana, come ad esempio mangiare avocado toast. La Gen Z (quella delle persone nate tra il 1997 e il 2012) viene dipinta in termini più entusiasti: gender fluid, attenta alla sostenibilità ambientale, meno influenzabile dalla retorica dei brand e abituata a fare scelte (e acquisti) più in linea con i propri valori.
Ogni volta che leggo articoli che pretendono di spiegare chi sono la mia generazione o quelle venute prima o dopo, non posso fare a meno di chiedermi quale sia l’utilità di questo genere di etichette. Eppure non posso negare che sia capitato anche a me di servirmene spesso, nella vita personale come in quella professionale.
Per lavoro mi è capitato di scrivere articoli che provassero a spiegare un certo trend in voga tra millennial o zoomer (che è solo un altro modo per indicare la Gen Z) e chissà quante volte mi è capitato di aver apostrofato scherzosamente amicə, parentə e colleghə con un ok boomer, perché avevano fatto un apprezzamento su qualcosa di datato, non avevano colto una reference o scoprivano con colpevole ritardo una moda o un meme ormai passato da mesi.
Bobby Duffy, autore di The Generation Myth: Why When You’re Born Matters Less Than You Think, ha spiegato al Wall Street Journal come questa categorizzazione così marcata tra generazioni abbia senso di esistere solo come parte di una strategia commerciale o di uno storytelling aziendale. La narrazione su quanto le generazioni siano diverse tra di loro è infatti funzionale alla creazione di personas (cioè tipologie di consumatorə), ma se utilizzata come uno strumento sociologico può risultare faziosa.
Il dibattito generazionale alimentato dai media può considerarsi, a sua volta, un prodotto di consumo che ha bisogno di essere rinnovato continuamente per risultare più appetibile e spingerci a volerne sapere di più.
Il dibattito generazionale alimentato dai media può considerarsi, a sua volta, un prodotto di consumo
Secondo Refinery29, negli ultimi anni abbiamo visto fioccare articoli che spiegavano come ə millennials fossero naturalmente nomadi digitali, la cui massima ambizione era quella di lavorare in una start up o in un open space attrezzato con biliardino e ping pong, per sfuggire alle gabbie dell’ufficio tradizionale. Quando lə zoomer hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, i riflettori si sono velocemente spostati su di loro, senza che la narrazione costruita intorno al loro approccio al mondo del lavoro cambiasse granché. L’importante, in fondo, non era avere una storia nuova, ma semplicemente un nuovo soggetto da raccontare.
Un report della National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) ha ulteriormente confermato come queste differenze tra professionistə appartenenti a generazioni diverse non siano poi cosí eclatanti e che continuare a tracciarle contribuisce solo a rafforzare pregiudizi, bias e stereotipi già esistenti.
Come riporta The Atlantic, all’inizio di quest’anno il sociologo Philip Cohen ha scritto una lettera aperta alla Pew Research Center, uno dei principali think tank statunitensi in ambito socio-culturale, per chiedere di eliminare espressioni come Gen Z o baby boomer dai propri report. L’appello è stato sottoscritto da circa 170 ricercatorə, tuttə convintə che le etichette generazionali siano arbitrarie e incapaci di descrivere accuratamente la realtà.
Le differenze tra professionistə appartenenti a generazioni diverse non sono poi così eclatanti. Continuare a tracciarle rafforza pregiudizi e stereotipi
Tracciare confini cronologici netti tra le generazioni è praticamente impossibile, eppure è facilissimo cedere alla tentazione di farlo. Come tutti gli stereotipi, anche quelli generazionali tendono a radicarsi perché offrono una chiave di lettura semplificata a problemi complessi della società (precarietà lavorativa, elevato costo della vita, disoccupazione giovanile, e così via). Ci danno l’impressione di poter fare previsioni sul futuro e sulla possibilità che si verifichino o meno determinati cambiamenti.
Per citare l’articolo di De Pace dal titolo Le Generazioni non esistono: “la nozione di generazione è diventata un’unità di misura attraverso cui cerchiamo di dare un senso al nostro rapporto con gli altri e di discutere i fenomeni che caratterizzano la società, ma non sempre si rivela utile per generare un confronto costruttivo o per osservare con sguardo critico la realtà”.
Mi viene in mente una cosa che ho letto tempo fa sul New Yorker a proposito dell’oroscopo, che dice che l’approccio meticoloso e pseudo-scientifico con cui parliamo di astrologia nasce dall’esigenza di analizzare noi stessə e lə altrə in maniera distaccata. È liberatorio e incredibilmente confortante poter giustificare i propri difetti ascrivendoli all’interno di un quadro più vasto.
In altre parole, attribuire determinate caratteristiche a una persona solo in quanto Millennial, Boomer o Zoomer non è poi troppo diverso dal dire che si comporta in un certo modo perché è Gemelli ascendente Capricorno.
Pensando di poter superare queste categorizzazioni, da un po’ di tempo a questa parte ho cominciato a definire me stessa con il neologismo perennial, coniato da Gina Pell nel tentativo di offrire maggiore inclusione. Secondo la definizione proposta da Treccani, i perennial sono persone in grado di adattarsi ai cambiamenti e alle novità, a prescindere dal sistema di classificazione basato sull’età. Ma in fin dei conti, per sfuggire a un’etichetta, ho finito per appiccicarmene addosso un’altra. Per sentirmi diversa, creativa, speciale. Forse bastava dire che sono Scorpione.