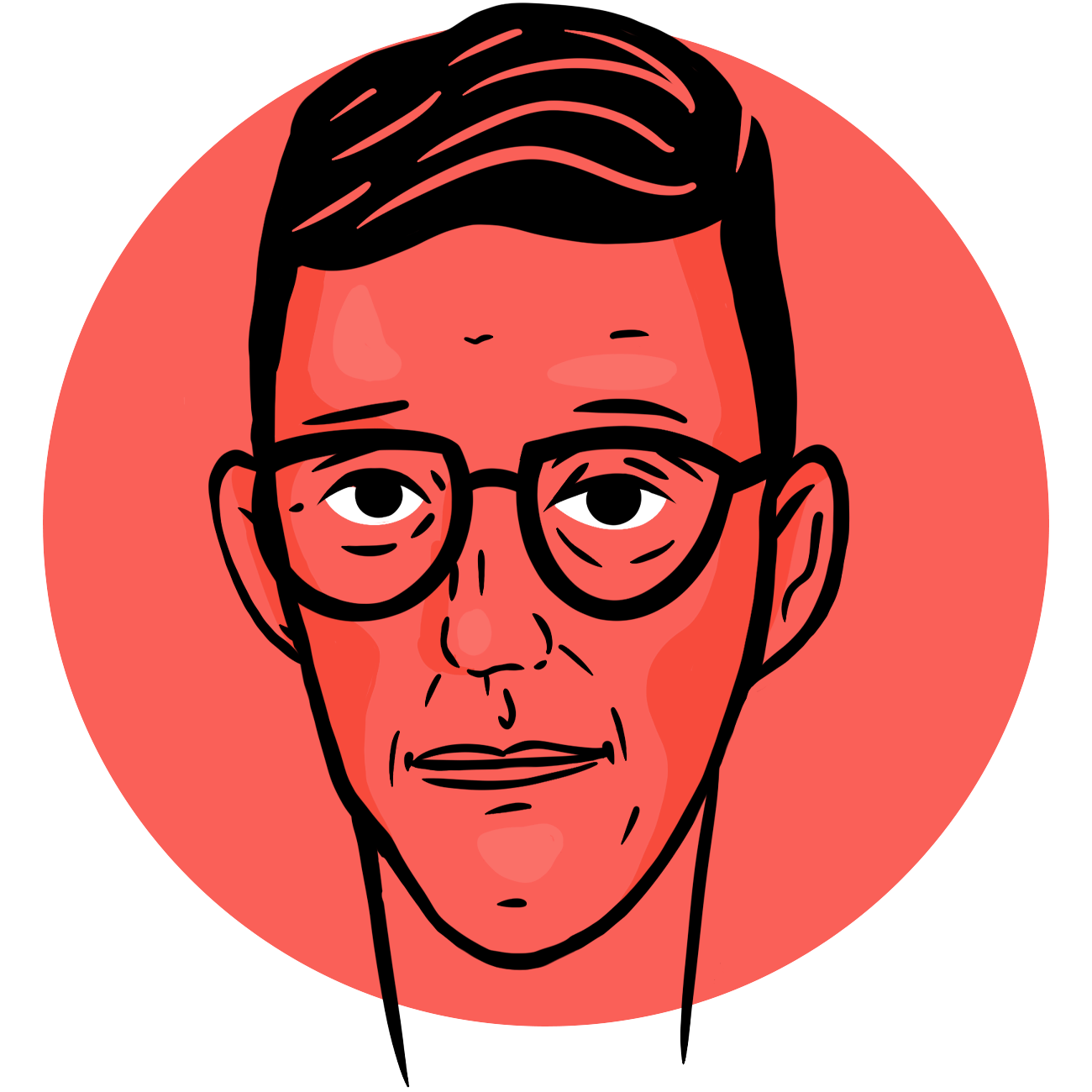C’era una volta il Team Sky. Prendeva il nome dalla celebre piattaforma televisiva e vestiva dei suoi colori diciassette giovani ciclisti.
Lo scorso anno, dopo che la squadra aveva fatto saltare l’asfalto vincendo tutto, Sky ha deciso che non aveva più soldi da far girare nelle due ruote. Così è arrivata Ineos, terza azienda di prodotti chimici al mondo, che ha adottato otto orfani in calzamaglia e l’abbronzatura da manovale. Ma come si fa a tifare per una squadra che cambia nome?
Quello che fino al giorno prima era il team Sky, con lo stesso manager, gli stessi meccanici, le stesse biciclette e circa gli stessi corridori, è diventato team Ineos Grenadiers. Ma cosa comporta cambiare il nome? Che farsene dell’attaccamento alla maglia, se la maglia cambia? È difficile per un tifoso percepire l’identità di qualcosa che non ha neanche un nome, ma lo prende in prestito da uno sponsor.
Il naming di una squadra dovrebbe essere come un tatuaggio che permane nel tempo. Nel ciclismo invece i nomi dei team sono più simili ai trasferibili all’acqua, quelli che si trovavano dentro i sacchetti di patatine San Carlo, andavano via alla prima doccia. Del vecchio team Sky neanche la pagina wikipedia esiste più, è stata sovrascritta.
Ma come si fa a tifare per una squadra che cambia nome?
Cambiando campo, nella genesi calcistica molte squadre prendono il nome dalla città di appartenenza: in questo caso si usa il genere maschile per distinguerle dal toponimo, che solitamente è femminile. In altri casi il nome deriva da un aggettivo territoriale: la Fiorentina, l’Udinese. Come per ogni cosa, esistono eccezioni: l’Atalanta di Bergamo, la Juventus di Torino e molte altre.
Una su tutte è la bellissima storia del Lanerossi Vicenza della stagione 53′–54′, che mise il monogramma dell’impresa tessile sulla divisa e ne ereditò anche il nome. Viene considerata la prima embrionale sponsorizzazione calcistica di sempre.
Per trovare un vero tentativo di sponsorship commerciale dobbiamo aspettare il 1972. La Eintracht Braunschweig era una piccola squadra del campionato tedesco senza risultati e in crisi d’identità. Il presidente incontrò fortuitamente Günther Mast, proprietario della ancora poco nota Jägermeister e l’accordo venne da sé: l’azienda di liquori chiedeva di esporre il proprio marchio, la testa stilizzata di un cervo, sulle divise della società sportiva. In cambio sarebbe arrivato un pagamento tale da coprire ampiamente il buco nel bilancio economico della squadra.
Il “Lanerossi Vicenza” mise il monogramma dell’impresa tessile sulla divisa e ne ereditò il nome
Unico cavillo tecnico: la federazione permetteva di cucire sulle divise esclusivamente gli stemmi dei vari club. Così durante l’assemblea societaria venne votato a maggioranza un restyling dello stemma, facendolo coincidere al marchio Jägermeister. La notizia creò scandalo fra i puristi sportivi. Nessuno immaginava che da lì a breve i brand avrebbero iniziato a comprarsi non solo le divise, ma anche i nomi delle squadre stesse. La storia è ricca di casi anche piuttosto estremi. Il marketing aveva compiuto il primo passo verso il mondo delle sponsorship, fenomeno che coinvolse ogni altro sport nei decenni a seguire.
In Formula Uno non esistono team o club, ma si parla invece di scuderie, come se si trattasse di cavalli. E la cosa ha un senso. L’unità di misura cavallo-vapore nasce proprio per fare un parallelo fra la potenza di una vettura e la forza motrice dell’animale in questione. In pista, solo Ferrari, McLaren e Williams possono vantarsi di non aver mai cambiato nome dalla loro nascita. Per tutte le altre scuderie è stato un continuo passaggio di proprietà che ha imposto diversi cambiamenti di nome e identità.
Il primo grande strappo nell’approccio tradizionalista al naming delle quattro ruote è stato il caso Red Bull, che prima di impegnarsi ufficialmente tentò un ingresso morbido nel circuito con quella che venne chiamata scuderia Toro Rosso.
Nessuno immaginava che da lì a breve i brand avrebbero iniziato a comprarsi non solo le divise, ma le squadre stesse
Ma lo sport che ci ha abituato alla presenza dei grandi brand è stato il ciclismo storico degli anni ‘70, quello di pancia e della prima televisione a colori. Ha portato i grandi marchi nelle nostre vite e li ha resi normali. Ci ha liberato dal bisogno di credere che i nomi delle squadre fossero custodia di una storia sacra e impossibile da scalfire.
Che meraviglia quelle maglie in lana, iconiche e impossibili da indossare, che ci hanno intrappolato per sempre in questo sentimento sospeso dal retrogusto commerciale. La Faema, la San Pellegrino, la Dreher, la Brooklyn. E i nostri eroi vestivano i colori di caffè, bibite, birre, gomme da masticare. Credevamo di tifare e invece stavamo consumando, lentamente educati a riconoscere quei nomi per poi ritrovarli altrove.