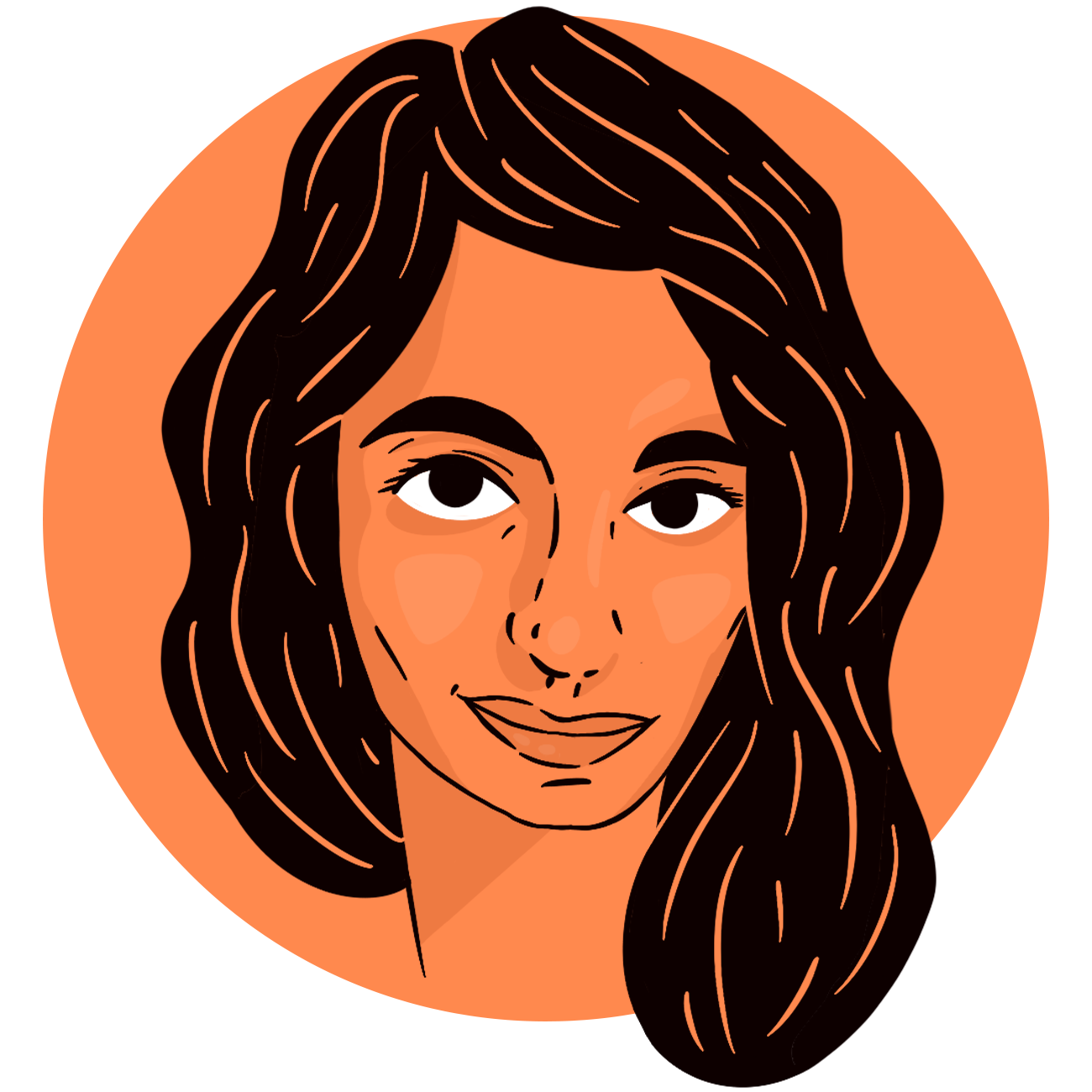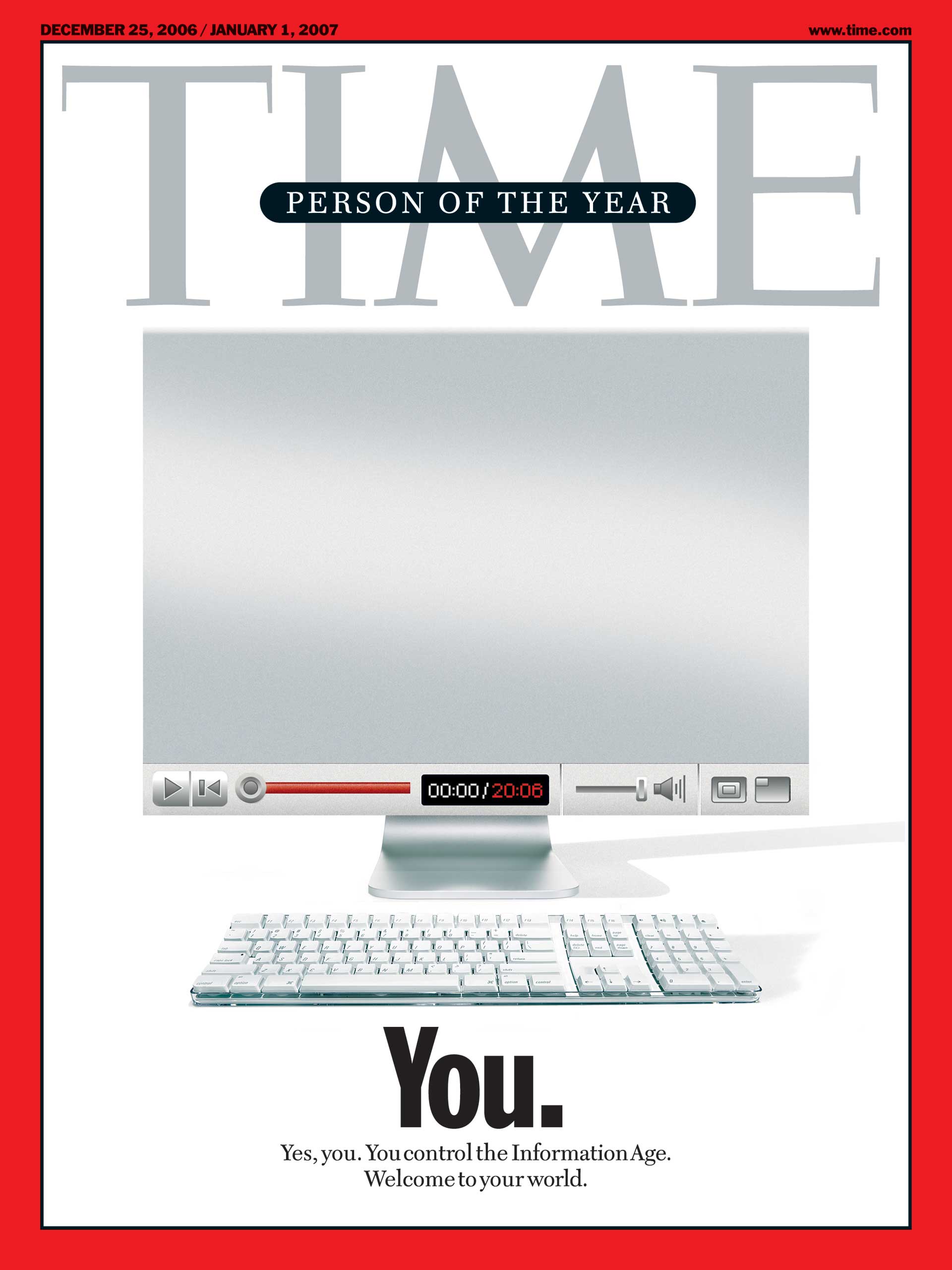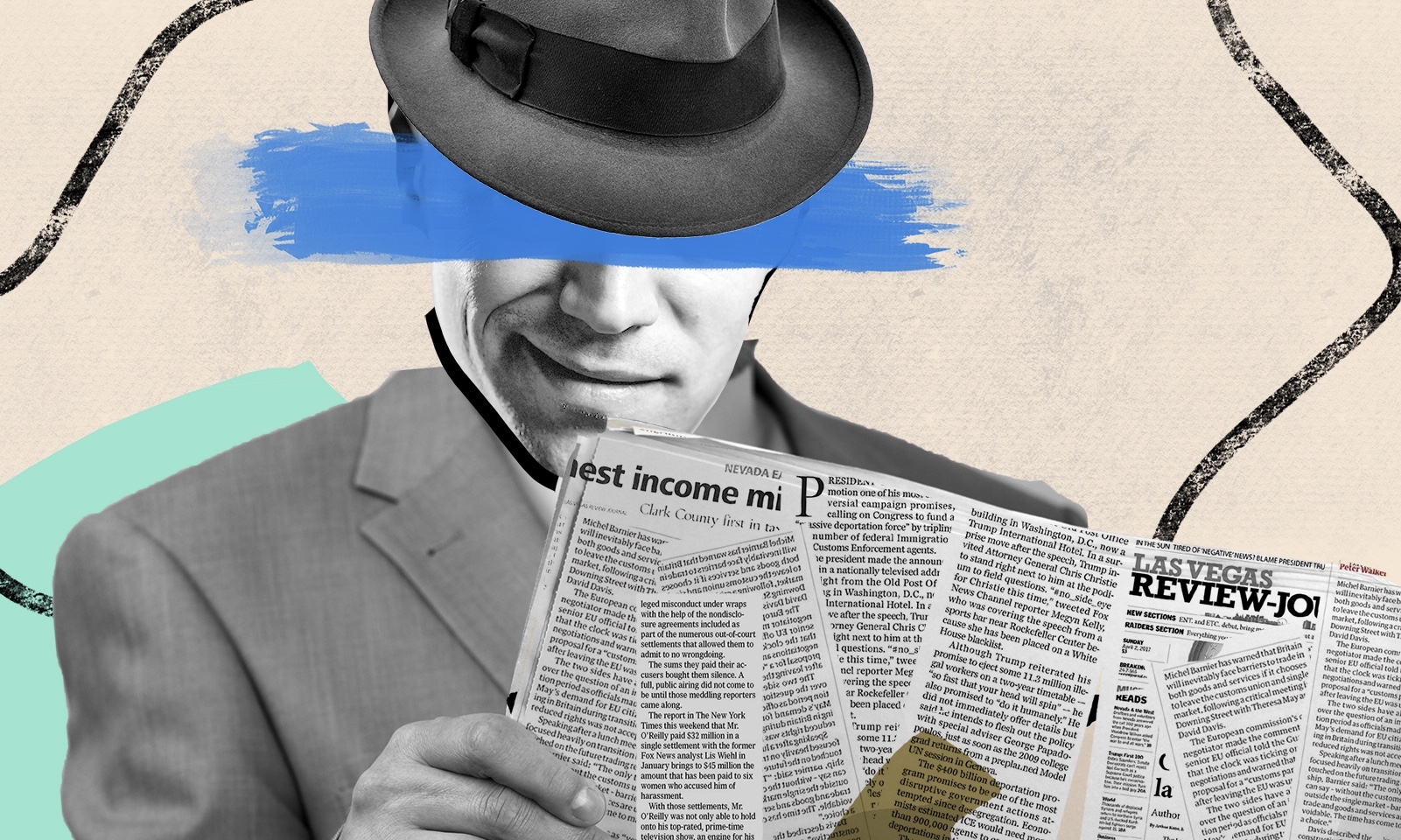
È una sensazione che ho sempre accarezzato, ma in questi ultimi mesi ne ho avuto definitivamente la conferma: i giornali ci odiano. Ci tartassano di informazioni senza informarci davvero, non ci aiutano a formare opinioni, danno spazio a ciò che ci confonde, ci fa incazzare, ci deresponsabilizza.
Da quando è scoppiata la pandemia, ogni giorno su qualsiasi quotidiano impazzano i bollettini, le mezze frasi, i titoli parziali per farci cliccare, per poi scoprire una non-notizia, perché non c’è ancora nulla di certo. Allora di che cosa stiamo parlando? Parliamo di click, di sponsor pubblicitari, di chi corre a diffondere cose. Ma di certo non parliamo di notizie. Non più.
Nelle ultime settimane i nuovi DPCM stanno catalizzando l’attenzione, ma è solo una delle fattispecie che possiamo portare ad esempio, in questo marasma pandemico.
Con la pandemia ogni giorno sui quotidiani impazzano i bollettini, le mezze frasi, i titoli parziali
Saranno ancora presenti negli occhi di tutti i video di centinaia di persone accalcate in stazione per rientrare al sud, a marzo, a fronte di una bozza di decreto divulgata senza certezze. Trattandosi di una bozza, appunto.
La domanda che sorge spontanea è: che cosa è andato storto? Quando c’è stato, guardandoci indietro, il punto di rottura? Quando le cose hanno cominciato ad essere esattamente come sono?
Un po’ come la storia della rana bollita, che se ne accorge troppo tardi perché l’acqua è arrivata a bollore pian piano. Non siamo stati immersi in questa condizione in maniera brusca, altrimenti ce ne saremmo accorti. Forse.
Cosa è andato storto? Quando c’è stato, guardandoci indietro, il punto di rottura?
La stampa è stata appellata e riconosciuta come “quarto potere”, fondamentale in democrazia, perché responsabile nell’applicazione dei cittadini del loro diritto al voto, aiutandoli a formarsi opinioni, ad essere aggiornati su ciò che accade, per poter essere chiamati – ed essere preparati a farlo – a svolgere le funzioni sociali e democratiche.
Ma quand’è che le notizie hanno cominciato a lavorare in funzione dei click, quand’è che i giornali si sono avvitati su narrazioni distorte in maniera tanto polarizzata quanto discorde?
La prima risposta possibile è che il momento di rottura sia avvenuto quando abbiamo smesso di vedere l’informazione come un processo attivo, considerandolo come qualcosa che arriva dall’alto. Io vengo informato, a scapito del io mi informo.
Abbiamo smesso di vedere l’informazione come processo attivo, considerandola come qualcosa che arriva dall’alto
L’informazione deve necessariamente essere un processo attivo, fatto di selezione. Un iter che tenga conto dei differenti punti di vista – più o meno dichiarati – arrivando a consolidare opinioni sulla base di più aspetti. Opinioni costruite su elementi solidi, strutturati, argomentabili. Soprattutto difendibili.
La seconda ragione possibile è stata l’accelerazione in corso. L’informazione ha cambiato la sua temporalità: da tempi accettabili a in tempo reale. Il tempo reale significa adesso, prima di subito, lo spazio di un refresh o di un click. Deve esserci tutto. Forse anche quello che non c’è. Forse – soprattutto – quello che non serve, ma che fa presenza. Che riempie le pagine.
Poco a poco abbiamo perso le redini dell’informazione: siamo diventati fruitori, non più destinatari. Ci passano mille informazioni sugli schermi e l’attenzione finisce su chi strilla meglio o chi spaventa di più. Ci colpiscono storie legate ad emozioni come la paura, la rabbia, la tristezza. La felicità non è così vendibile. Genera meno identificazione, spesso invidia.
Dev’esserci per forza tutto. Anche quello che non serve e che fa presenza, che riempie le pagine
Un articolo che intervista la famiglia di un assassino dipingendolo come “bravo ragazzo” genera più curiosità di un’analisi di un sociologo sul tema del razzismo, su quanto sia radicato e nascosto sotto il tappeto all’occorrenza, e sul perché questi episodi siano sistemici e da analizzare nella loro radice, non nella loro sintomatologia.
La cosa più complessa, in questo ecosistema di informazioni urlate, è trovare qualcuno che abbia il tempo e la voglia di spiegare. Qualcuno che ci racconti la realtà, con onestà, proponendoci riflessioni e non mistificazioni. Qualcuno che ammetta i propri errori, come il New York Times ha fatto di recente. Un tipo di trasparenza che oggi, solo a pensarci, ci proietta in un universo utopico.